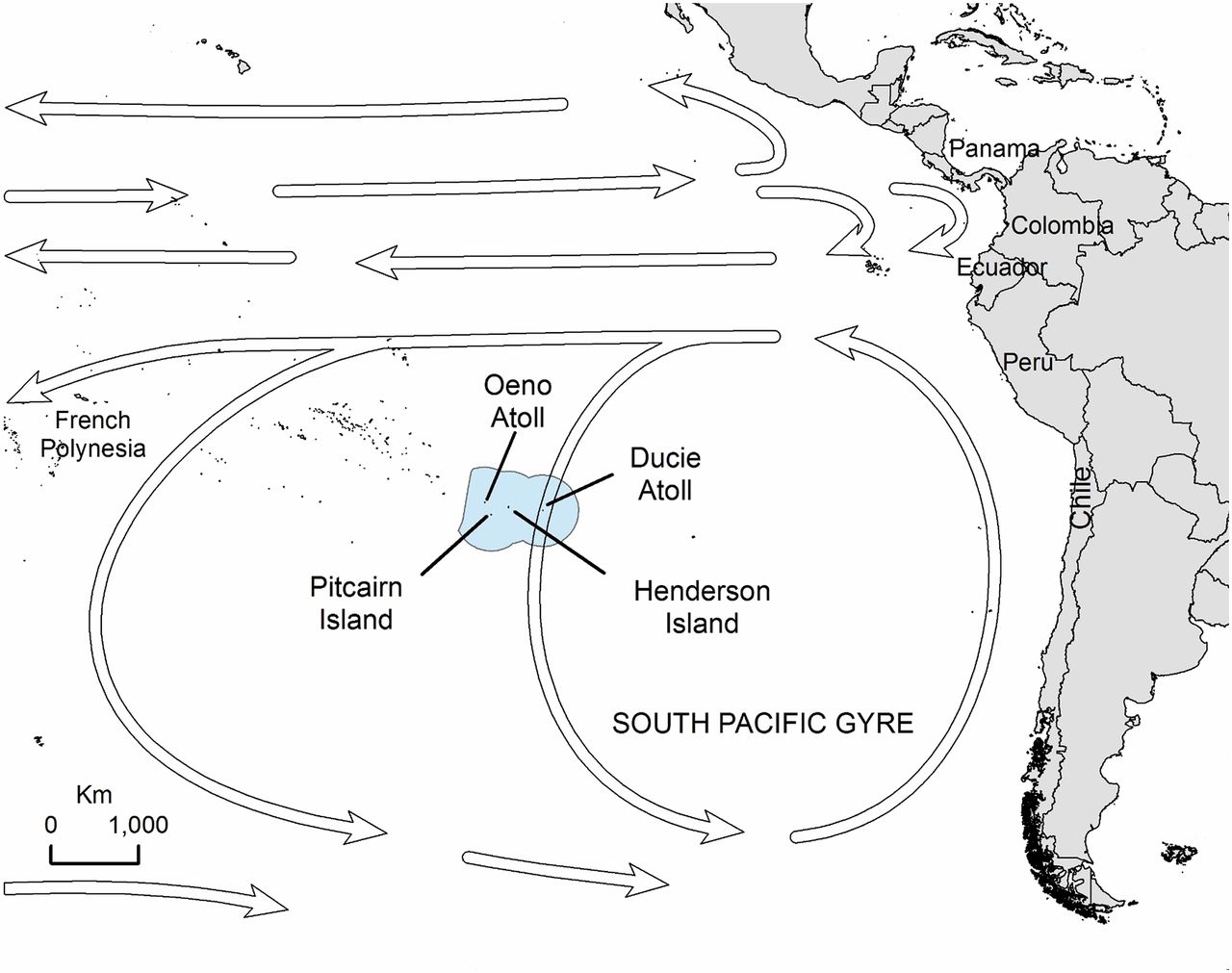Nell’estate del 2007 il ministro dell’Economia Tommaso Padoa-Schioppa era in cerca di alleati in vista di una complicata battaglia politica sulla riforma delle pensioni. La sinistra radicale, che appoggiava il suo governo, chiedeva l’abolizione dello “scalone Maroni” – un brusco aumento dell’età pensionabile – che avrebbe significato una spesa aggiuntiva per le pensioni di miliardi di euro l’anno. Secondo Padoa-Schioppa, invece, lo Stato spendeva già troppo per i suoi cittadini più anziani e così facendo aveva finito con il trascurare le nuove generazioni. È la famosa “questione generazionale”: gli anziani sono il pezzo di popolazione in assoluto meno toccato dalla crisi economica di questi anni e possiedono una ricchezza sbilanciata e in continuo aumento rispetto a quella dei più giovani, che invece continua a ridursi.
Quando arrivò il momento di trattare con partiti, associazioni e sindacati, Padoa-Schioppa decise che accanto ai rappresentanti dei pensionati avrebbe ascoltato anche quelli dei giovani, con l’idea che avrebbe trovato in loro un alleato. Ma trovare chi difendesse gli interessi delle nuove generazioni non fu facile. Padoa-Schioppa chiese aiuto a Tito Boeri, allora professore dell’Università Bocconi. Boeri gli consigliò di interpellare i rappresentanti degli universitari e quelli del Forum nazionale dei giovani, un’organizzazione non molto conosciuta che raggruppa le principali associazioni giovanili, da quelle cattoliche a quelle dei partiti. L’incontro si svolse il 9 luglio 2007 e Padoa-Schioppa rimase deluso. L’intervento dei ragazzi del Forum Giovani non fu particolarmente incisivo e la storia ne ha oramai perso il ricordo. Le trattative furono vinte dagli anziani, tanto per cambiare, e i pensionati ricevettero decine di miliardi di euro grazie all’abolizione dello “scalone Maroni”. Dieci anni dopo quell’incontro, la questione generazionale è persino più attuale di prima: anni e anni in cui lo Stato ha privilegiato ulteriori interventi di spesa sulle pensioni a quelli sui contratti precari e la mobilità sociale, per esempio, hanno contribuito a creare la situazione certificata dall’ISTAT nel suo ultimo rapporto: i più giovani in Italia sono il gruppo sociale più qualificato (dopo i manager) e allo stesso tempo il più povero.